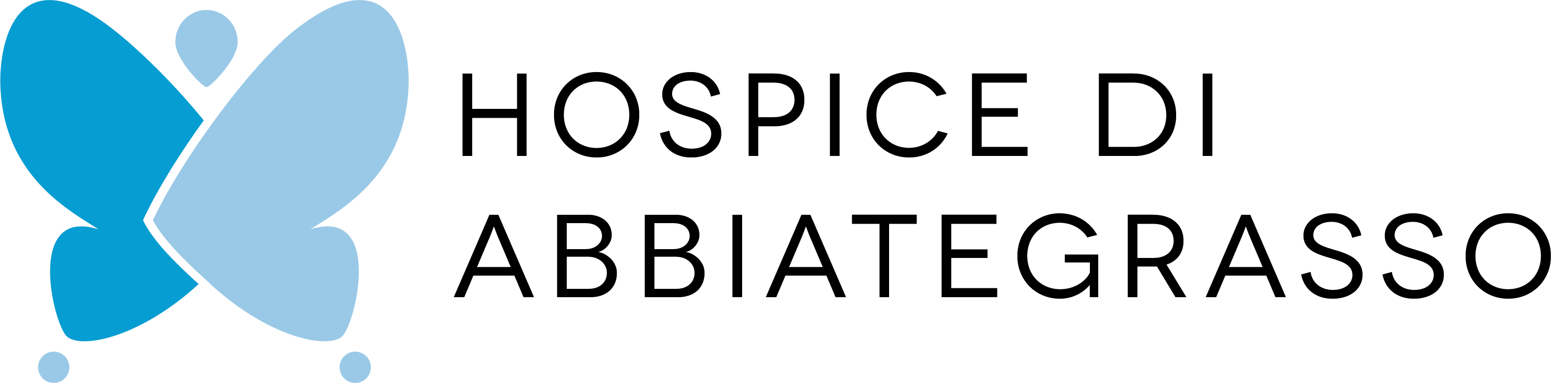Il PAI: cos’è e perché è fondamentale nel contesto sociosanitario e sanitario

Il PAI è un acronimo che in Italia individua almeno tre ambiti completamente diversi tra loro. Nel contesto ambientale indica il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, in quello scolastico il Piano Annuale per l'Inclusione mentre nel settore sanitario e sociosanitario sta a significare Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).

Cosa si intende per PAI?
Come detto, il PAI nel contesto sociosanitario e sanitario rappresenta il Piano Assistenziale Individualizzato che è di fatto un documento di natura clinica e organizzativa. Esso rappresenta una sintesi che comprende ed espone specifiche informazioni rispetto alle esigenze della persona malata.
Lo scopo del piano è definire e mettere in atto una strategia terapeutica e assistenziale che abbia come obiettivo quello di facilitare il raggiungimento della migliore condizione di salute e benessere per il paziente.
Chi fa il piano assistenziale individualizzato?
Il piano può essere sviluppato nei diversi contesti di cura. Ad esempio può essere redatto nell’ambito delle strutture residenziali per anziani o disabili e nelle cure domiciliari. La personalizzazione del PAI, in base alle diverse condizioni cliniche, psicologiche, sociali di ogni paziente, è la sua caratteristica fondamentale.
Nel contesto delle cure palliative il PAI assume solitamente caratteristiche peculiari che lo differenziano da altri setting: il percorso assistenziale dei pazienti in Hospice e a domicilio è infatti spesso particolarmente complesso e differenziato per ogni persona malata, ed è caratterizzato da tempi brevi e da una rapida evoluzione dei bisogni che comporta una costante rivalutazione e rimodulazione del PAI.
Per questo è importante prevedere un costante coinvolgimento di familiari e caregiver, frequenti momenti di confronto tra gli operatori che compongono l’equipe e una forte flessibilità nei modelli organizzativi.
Quali sono le 4 fasi del PAI?
Per redigere il Piano e applicarlo è importante:
- Osservare il paziente. In questa fase è fondamentale focalizzare l’attenzione sull’osservazione delle specificità che caratterizzano la persona malata al fine di formulare una valutazione specifica dei suoi bisogni in ambito clinico ma anche nella sfera, relazionale, psicologica, sociale e spirituale.
- Pianificare e coordinarsi. Alla fase di valutazione segue una pianificazione degli interventi e il coordinamento degli operatori coinvolti nelle attività. È inoltre importante definire i tempi per la valutazione degli obiettivi di cura e assistenza che ci è prefissati di raggiungere.
- Erogare l’intervento effettivo. Una volta individuati con chiarezza gli obiettivi e gli scopi è possibile dare seguito alle attività mettendo in atto quanto espresso durante la fase di pianificazione.
- Verificare e adeguare gli interventi nel corso del tempo. Il PAI non è uno strumento statico e per essere efficace è necessario verificarne e monitorarne con periodicità i risultati delle attività indicate.
Chi redige il piano assistenziale individualizzato?
Redigere un PAI significa solitamente coinvolgere una pluralità di figure professionali. Se il paziente è in carico ad una struttura (RSA, Hospice, ecc) può essere il medico palliativista responsabile, o altre figure come l’infermiere, a far partire il processo e successivamente a registralo nella cartella clinica della persona assistita.
Nell’ambito della Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) il procedimento di stesura è normalmente avviato dal medico di medicina generale.
PAI compilato: quali figure sono coinvolte?
A seguito delle fasi di osservazione e pianificazione, una volta compilato il PAI, è importante che il coinvolgimento degli operatori e dei familiari continui. A seconda dei bisogni individuati possono essere coinvolte diverse figure professionali: educatore, terapista della riabilitazione, assistente sociale, infermiere, psicologo, OSS o altri.
Ad esempio l’OSS può svolgere un ruolo fondamentale nella definizione e nel monitoraggio del PAI. L’OSS, nel caso di un hospice, è spesso la figura che maggiormente interagisce con il paziente e può rilevare bisogni o aspetti critici difficilmente individuabili dagli altri operatori. Per questo è fondamentale il suo apporto sia nella fase di definizione che in quella di verifica del PAI.
Cosa si intende per PAI, PEI, PTI?
Avendo fornito una definizione specifica di PAI è ora opportuno individuare altri strumenti di pianificazione che possono essere utili. Tra questi vi sono il PTI (Piano Terapeutico Individuale) che rappresenta uno strumento altamente personalizzato utilizzato molto spesso nell’ambito geriatrico o psichiatrico. Una delle caratteristiche di questo Piano riguarda la domiciliarità degli interventi.
Il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) è invece comunemente usato in ambiti educativi scolastici ed extra-scolastici come centri diurni, comunità per minori, servizi per disabili, progetti territoriali. Infine il Progetto di vita (per disabili ai sensi della Legge 328/2000, art. 14) è un documento strategico che mira a costruire un percorso complessivo per la persona con disabilità, mettendo al centro i suoi desideri, bisogni, risorse e potenzialità, lungo tutto l’arco della vita.